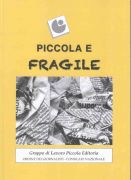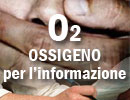Newsletter
Tieniti aggiornato sulle nostre ultime novità!
Comunicazione pubblica e new media: tra resistenze e nuovi spazi partecipativi
 La società civile. Esiste davvero? E’ reale o è un concetto che è sempre stato semplicemente utilizzato come alibi per definire ‘l’uomo che vive in un gruppo’, come sosteneva il saggio Aristotele? Che ruolo svolge nei confronti dello Stato? Ma soprattutto, come comunica?
La società civile. Esiste davvero? E’ reale o è un concetto che è sempre stato semplicemente utilizzato come alibi per definire ‘l’uomo che vive in un gruppo’, come sosteneva il saggio Aristotele? Che ruolo svolge nei confronti dello Stato? Ma soprattutto, come comunica?E-publicity, e-government, e-democracy, e-procurement, e-learning: in poche parole, la Democrazia Digitale. Ma chiediamo direttamente all’autore del libro di spiegarci come funziona, come e quando si utilizza.
La considerazione non è mia ma di Giuseppe De Rita. E’ la realtà di questi anni, in cui molto si è fatto, ma poco si è prodotto in termini di efficacia comunicativa delle istituzioni. Questo spiega le difficoltà che oggi il Paese vive nel tentativo di organizzare proiezioni d’immagine coerenti con le proprie strutture d’interesse e più in generale a supporto di una identità competitiva ancora troppo fragile. Al contrario altri paesi sono molto avanti nel branding pubblico e nella capacità di orientare le proprie logiche comunicative rispetto agli interessi di riferimento.
L’attitudine autoreferenziale del nostro sistema pubblico non è in discussione. E’ un fatto e ha cause lontane nel tempo, non ultimo la scarsa attenzione dimostrata nella formazione della classe dirigente pubblica, per troppo tempo considerata lavoratori di serie b. Oggi paghiamo la conseguenza di un sistema pubblico considerato e utilizzato per troppo tempo come un “deposito elettorale”.
Mutuando un’analisi che ha finalità e ambizioni ben più alte come quella di Agamben, è plausibile affermare che sia proprio nel presupposto della coscienza legittimità delle istituzioni che trovano fondamento le ragioni più profonde della crisi della comunicazione pubblica italiana. Una crisi che, nata nel dopoguerra come reazione alla iper-comunicazione di regime, ha prodotto nella PA prima la regola del silenzio e segreto, lasciando ai partiti politici la funzione di cerniera comunicativa con i cittadini. E con la crisi del sistema dei partiti ha generato il tentativo da parte delle istituzioni di risolvere la crisi attraverso la legislazione di settore.
Proprio gli anni Novanta hanno rappresentato il tentativo di colmare quel vuoto di legittimità delle Istituzioni cadute in profonda crisi con i fatti di tangentopoli. E il conseguente tentativo di istituire per legge la comunicazione pubblica nel Paese. Di qui, per un verso, una comunicazione pubblica che non è mai riuscita veramente a intercettare le dinamiche del cambiamento sociale e di racconto del Paese; per altro verso, un’iniziativa legislativa che ha tentato di dare risposta alla domanda di maggiore comunicazione, partecipazione, inclusione da parte dell’opinione pubblica, ma che non ha mai saputo affrontare la natura reale della sua debolezza Appunto, più di natura istituzionale che comunicativa. La rete ha, a mio parere, ampliato questo disallineamento.
Pubblico interesse significa andare oltre la comunicazione dell’apparato pubblico per orientare lo sguardo a tutto ciò che ha valenza pubblica: dal sociale, al politico, ai sistemi della rappresentanza, alla dimensione solidale, al brand pubblico locale e nazionale, al tema del non profit fin’anche al sistema d’impresa, quando punta a orientare il dibattito pubblico e non a vendere prodotti. Tutto questo è comunicazione pubblica e con questi ambiti le istituzioni debbono relazionarsi, superando definitivamente la logica organizzativa della legge 150, che si è dimostrata un fallimento.
La società civile ha oggi la grande occasione di tornare protagonista del proprio futuro, aprendosi alle dimensione partecipative e relazionali della nuova sfera pubblica digitale. Uno spazio che ha reso liquidi i confini non solo spaziali, ma anche temporali; che ha reso disintermediati i processi di comunicazione; che consente forme di partecipazione mai sperimentate prima. L’attivismo digitale è la nuova frontiera dalla politica, rispetto a cui tutti siamo portatori e potenzialmente aggregatori di interessi. Caduta la barriera ideologica dell’appartenenza partitica e moltiplicatesi all’infinito le dimensioni della comunicazione, nulla si frappone oggi alla relazione tra società civile e istituzioni.
La Post-comunicazione è in essenza la capacità del sistema Paese di rappresentare interessi collettivi e individuali sui diversi piani della comunicazione. Finito il tempo dello Stato-nazione come unità di misura dei processi comunicativi, un nuovo ruolo attende oggi la comunicazione pubblica. L’approccio post-comunicativo spoglia di responsabilità l’apparato pubblico per orientarsi al raccordo con una società civile mediatizzata, globale e autonoma nella auto-rappresentazioni, nel rapporto con le istituzioni e nella determinazione delle priorità. Tutti siamo digitali e organizziamo la nostra vita pubblica attraverso i nuovi media partecipando al racconto complessivo del Paese.
Chi è Alessandro Papini – Classe 1974, docente di comunicazione pubblica presso l’Università IULM , è stato dal 2010 al 2014 direttore Comunicazione e Relazioni Internazionali della Provincia di Milano. Laurea in scienze politiche con specializzazione in comunicazione, è giornalista, autore di saggi e articoli scientifici. Tra i più giovani comunicatori istituzionali italiani, ha lavorato per enti pubblici e sistema privato. E’ stato consulente del Ministero dell’Economia (2003-2008) per i progetti twinnings di comunicazione internazionale. Nel 2010 e nel 2011 è stato visiting scholar presso la George Washington University. Nel 2012 ha pubblicato “La Comunicazione pubblica locale” e nel 2014 “Post-comunicazione”, entrambi per Guerini editore.
Riforma CNOG
22.736
giorni
QUADERNI CNOG
Lo scaffale